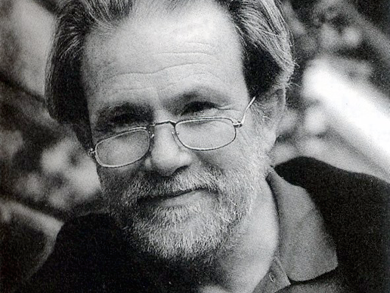Luca Tosi

Nato a Pisa il 25/05/47 si laurea con il massimo dei voti nel 1972 presso la facoltà di architettura di Firenze con una tesi sulla pianificazione territoriale e sistemi residenziali nel basso Valdarno con Edoardo Detti.
L’ideologia del ’68 permea gli anni dell’Università e determina una scelta di campo che caratterizzerà la sua carriera professionale.
Dal 1973 al 1975 lavora come socio professionista della società UTCO, che fornisce servizi tecnici alle cooperative di abitazioni della Lega.
Inizia l’attività professionale in contatto con le strutture cooperative della Lega per le quali realizza i primi progetti di residenze. Nel 1978 fonda insieme a tre colleghi sodali fin dagli studi, la società Abitcooper che si occupa di “housing” cooperativo nella quale svolge prevalentemente attività di progettazione fino al 1987 anno nel quale la società si scioglie.
Nel 1991 costituisce uno studio associato con l’Architetto Alberto Pacciardi ampliando l’attività professionale al recupero, alla progettazione di riqualificazione ambientale, alla pianificazione microurbana.
All’attività nello studio affianca dal 1999 la professione esercitata con studio in proprio nella quale si occupa prevalentemente di progetti privati (recuperi, ristrutturazioni, restauri).
Molti i progetti pubblicati da riviste specializzate (Casabella, l’Architettura, Controspazio, Modulo, Costruire in Laterizio, Edilizia popolare ecc.).
Le realizzazioni più importanti si annoverano tra i progetti residenziali di scala microurbana: complesso residenziale località “Limoncino”, Livorno (progetto 1986, realizzazione 87/88); intervento coordinato di 266 alloggi a Livorno, località Scopara (progetto1989, realizzazione 90/95); quartiere “Anna Frank”, Viareggio, località Forcone (progetto1989, realizzazione 90/93); intervento coordinato di 170 alloggi, Comune di San Giuliano Terme, progetto 1994, realizzazione 96/01.
Tra i principali progetti di recupero il restauro del “Rivellino di S. Marco” a Livorno (2001) con gli architetti Aldo e Franco Luperini, il restauro del “Grand'Hotel Palazzo” sul lungomare a Livorno (2004), il recupero dell'opificio Remaggi a Navacchio (2004), il progetto di restauro di palazzo Mastiani a Pisa (2003).
Nel 2012 si chiude lo studio associato Pacciardi & Tosi e l'attività continua nello studio privato insieme al figlio Matteo.
- INTERVISTA A LUCA TOSI -
Parlaci della tua formazione, come si possono riassumere le tue esperienze formative e professionali fino ad oggi. Quali i tuoi maestri se ce ne sono? Quali i riferimenti culturali in architettura?
Gli anni della mia formazione universitaria, tra la metà del ‘60 e il ’70. furono caratterizzati dall’impegno su temi sociali, caratteristica comune a molti studenti della facoltà di architettura di Firenze dove insegnavano docenti del calibro di Quaroni, Benevolo, Detti.
Le lotte politiche per la casa e per la riforma urbanistica che aprivano le porte ad una profonda trasformazione territoriale ed edilizia, sono state il terreno su cui ho iniziato, insieme ad alcuni colleghi con i quali avevo condiviso la formazione universitaria, a intraprendere l’attività professionale nel nascente movimento cooperativo per la casa aderente alla “Lega”. All’interno di questa opportunità operativa ho cercato di coniugare l’attenzione alla disciplina con la concretezza del complesso ciclo di produzione edilizia nella consapevolezza che ciò che riusciamo a realizzare non è ciò che “vogliamo” esprimere, ma ciò che “possiamo” esprimere.
Importante stimolo in quel periodo sono state anche le frequentazioni con personalità professionali emergenti nel contesto locale come Francesco Tomassi, Roberto Mariani, Massimo Carmassi.
Nel panorama dell’architettura le suggestioni più intense provenivano dalle opere di Luis Kahn con la loro asciutta monumentalità o dai dettagli di Carlo Scarpa. Un’occhio era rivolto anche all’architettura anglosassone alle loro esperienze di architettura civile di alto livello, e di personalità come James Stirlig o Denis Lasdun.
Come l’architettura esprime la cultura del nostro tempo e qual è il tuo approccio alla progettazione? Quali sono gli architetti o gli studi di progettazione italiani che maggiormente apprezzi in questo momento? E tra gli stranieri ?
Purtroppo l’architettura non ha più il peso e la considerazione che aveva nel passato quando era espressione di una cultura, di una civiltà. Le città storiche erano espressione di una comune volontà di rappresentazione, di un comune sentimento etico ed estetico. La città moderna, al contrario, è sintomatica della alienazione del cittadino dal contesto ambientale. Il disordine. l’eclettismo formale, la precarietà dell’ambiente non sono riscattati dagli sporadici tentativi di una architettura di qualità. E la disciplina, soprattutto in campo urbanistico sembra essersi arresa all’ingovernabilità delle metropoli moderne.
Per ciò che riguarda la mia esperienza ho sempre cercato, quando ho potuto, di lavorare a quella scala “microurbana” dove il progetto di architettura tenta di creare dei frammenti di tessuto urbano, nel quale la qualità architettonica va cercata più che nel singolo edificio negli spazi di realzione che si vengono a creare nel tessuto stesso.
Degli architetti italiani apprezzo quelli la cui architettura discende da un disegno teorico come Giorgio Grassi o Antonio Monistiroli.
Un altro architetto che stimo per la grande sensibilità nel conuigare modernità e storia è Francesco Venezia.
Nel panorama internazionale odierno dove l’architettura ha mutuato dalla moda la sua dimenzione multinazionale e la produzione dei megastudi è caratterizzata dall’autoreferenzialità del “marchio” (dov’e finito il genius loci ?) apprezzo le poetiche architetture latine di Alvaro Siza e l’attenzione ai fondamentali dell’architettura di Peter Zumthor (spazio, luce, materia).
Cosa significa e implica oggi, per un architetto, intervenire in un contesto ambientale fortemente storicizzato? O con presenze architettoniche di cui tener conto?
Nella mia formazione didattica ho imparato che il senso storico di una città sta nella sua stratificazione, nella quale si leggono i segni delle varie epoche anche se nel passato la spegiudicatezza ha fatto sì che opere, pur di valore, siano scomparse per far posto ad altre che si presumevano più importanti. Oggi, forse a causa di molti interventi maldestri, predomina un atteggiamento ostile all’inserimento di un linguaggio contemporaneo nel contesto della città storica. Ciò a mio avviso è dovuto anche alla scarsa formazione- preparazione critica in campo moderno che hanno le istituzioni di controllo (vedi soprintendenze o altri funzionari preposti al giudizio) che non sanno selezionare, con cognizione di causa, le proposte che vengono avanzate perché, spesso, manca la capacità di valutare, con coraggio e competenza, la qualità della proposta, e gli architetti per evitare il rischio di una bocciatura, intraprendono la più facile strada del falso storico.
Partecipi a concorsi di architettura e cosa pensi pensi dell’attiviotà concorsuale in italia oggi?
Partecipo sporadicamente a concorsi come esercizio personale conscio che raramente può uscirne un’esperienza di fare architettura. In Italia il concorso è utilizzato come escamotage di propaganda politica che raramente si traduce in un esito architettonico.
Cosa pensi delle nuove tecnciche di rappresentazione dell’architettura? Quanto è importante oggi il mezzo digitale?
L’architettura è architettura. Esiste però la necessità di comunicare a diversi livelli ciò che si intende realizzare. Occorre cioè prefigurare il risultato finale sia da un punto di vista formale che tecnico. In questo campo il disegno è sempre stato il mezzo principale per mediare la comunicazione. La tecnologia ci ha messo a disposizioni strumenti che agervolano notevolmente questo lavoro. A mio avviso comunque il disegno a mano libera resta lo strumento più diretto per trasferire il pensiero dalla mente al foglio.
Ciò spiega perché a monte di ogni progetto c’è sempre uno schizzo.
Come è organizzato operativamente il lavoro nel tuo studio? Quante persone ci lavorano ? Ognuno ha un compito preciso?
Attualmente ho due studi. Uno nel quale opero in qualità di associato con l’Arch Alberto Pacciardi con il quale ho condiviso, in varie forme, l’attività dal 1973. L’altro in cui opero a livello individuale in collaborazione con il figlio Matteo architetto anche lui.
In passato ho lavorato con società con addetti e dipendenti con una organizzazione articolata e specialistica. Oggi l’attività professionale ha ritrovato una dimensione più artigianale e sinceramente più confacente alla mia indole. D’altronde la situazione di crisi del nostro settore ci costringe ad una organizzazione del lavoro più flessibile avvalendosi prevalentemente di collaborazioni a progetto che rende per sua natura ondivaga la presenza di collaboratori nello studio.
Hai trasmesso a Matteo la passione per l’architettura?
Spero di sì perché questo è un mestiere che non si può fare senza passione.
Quali riviste di architettura legge?
Un tempo ero abbonato a molte riviste anche internazionali (Inglesi, Francesi e Giapponesi). Oggi considerato che pubblicano più o meno le stesse cose leggo solo Casabella, El Croquis, Il giornale dell’architettura.
Vorrei anche esprimermi a sostegno della collana dalla quale sto parlando, in quanto importante strumento di aggiornamento, confronto e stimolo per l’attività degli architetti sul proprio territorio.
Tratta dal n°136 del Dicembre 2005 della rivista Pantheon, notiziario dell’Ordine degli Ingegneri di Livorno.
Biografia.